Negli ultimi decenni l’architettura è sempre più concepita non solo come risposta ai vuoti costruiti, ma come strumento di rigenerazione urbana e sociale, capace di intervenire in modo mirato e significativo nei contesti degradata – un approccio spesso definito “urban acupuncture”, dove piccoli interventi attorno a nodi critici stimolano reazioni a scala urbana.
Questo paradigma si fonda sull’idea che l’architettura può diventare “agopuntura urbana”: agire sui punti di frattura del tessuto cittadino per rimettere in circolo flussi sociali, ecologici e culturali. Tale processo valorizza la dimensione organica del progetto, dove la composizione volumetrica e spaziale non è mero esercizio estetico, bensì strategia funzionale e identitaria: ricostruire continuità, riattivare relazioni e mettere in dialogo forma, funzione e natura .
Il risultato è una rigenerazione integrata, che non si limita a rigenerare fisicamente un luogo, ma lo riconnette ai bisogni della comunità – migliorando la qualità della vita, incentivando la coesione e stimolando dinamiche culturali e ambientali.

È esattamente in questo quadro che si inserisce il progetto “Bosco della Musica” dello studio di architettura internazionale Settanta7: un intervento che si pone come paradigma di ricucitura urbana, grazie a un disegno volumetrico rigoroso, un dialogo coerente tra spazi interni ed esterni, e l’adozione di materiali e geometrie ispirate alla natura. In questo contesto, l’intervista ai progettisti ci permette di comprendere il core progettuale alla base della scelta vincente, e di esplorare come questo progetto traduce in pratica tali principi in chiave contemporanea.
La genesi del progetto: natura, musica e riqualificazione
Il progetto nasce da un concorso internazionale terminato nel 2022 e dalla volontà di rigenerare un’area particolarmente degradata, quella di Rogoredo, con l’obiettivo di realizzare una cerniera tra il quartiere storico e l’espansione di Santa Giulia. Il concept trae ispirazione dalla natura, in particolare dalla forma di una foglia, che suggerisce le linee e le geometrie dell’intervento.
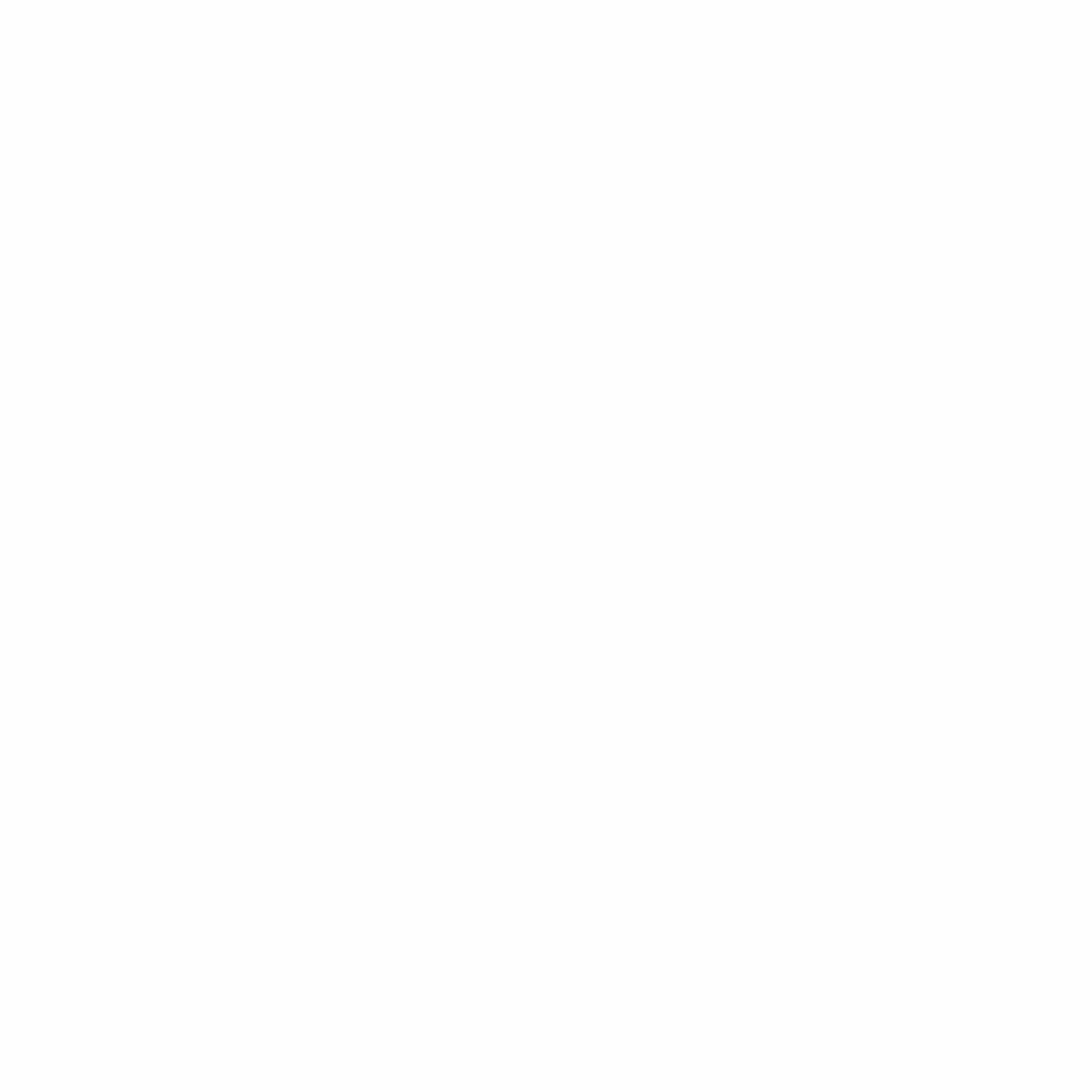
ARCH. MATTEO VALENTE – SETTANTA7
“Caratterizzare”
Il concept di per sé nasce dal rapporto con la natura. C’è un riferimento all’elemento della foglia che poi va a caratterizzare tutto il progetto. L’idea è che una foglia cada sul lotto e vada a delineare le forme architettoniche, ma anche urbane del progetto stesso.
L’obiettivo è restituire qualità urbana e sociale al contesto, creando un polo culturale e formativo che coniughi educazione, sostenibilità e apertura al territorio. Il progetto si propone come elemento di continuità tra architettura e spazio urbano, integrandosi con sensibilità nel tessuto milanese.
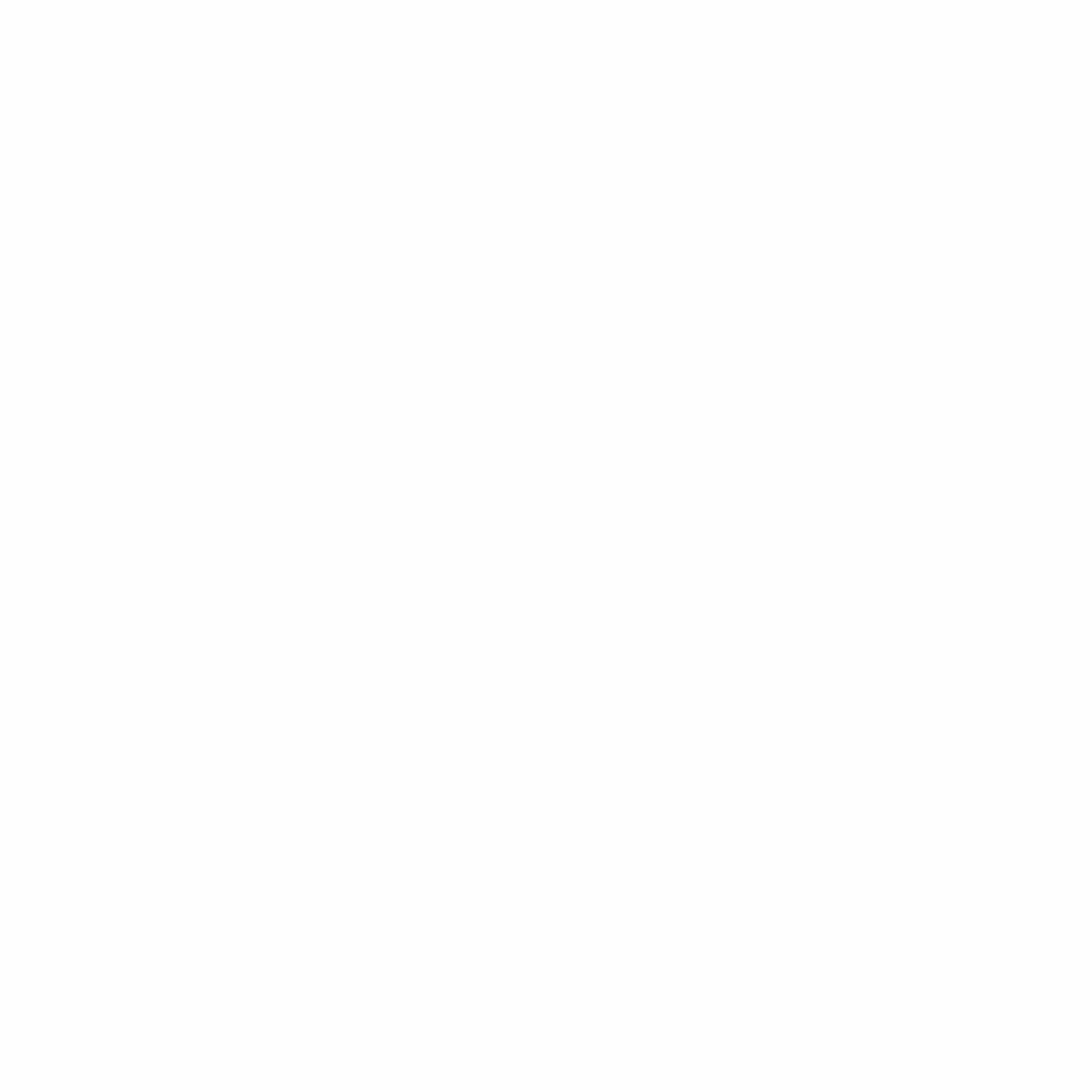
Il contesto urbano: da “vuoto” a cerniera di riqualificazione
L’area su cui sorgerà il “Bosco della Musica” è attualmente un vuoto urbano, risultato della dismissione di un’ex acciaieria e di successivi interventi di bonifica.
In passato e tutt’ora l’area era recintata e inaccessibile, con la presenza di una palazzina occupata e in condizioni di degrado. Questo intervento di riqualificazione si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge anche Santa Giulia e l’area interessata dai lavori per le Olimpiadi invernali del 2026. Il “Bosco della Musica” si pone come cerniera tra Rogoredo e Santa Giulia, fungendo da elemento di rilancio per l’intera area.
Campus contemporaneo: i caratteri distintivi
Tra i requisiti del concorso figurava il mantenimento della palazzina ex-Chimici, edificio vincolato che ha rappresentato un elemento generativo del concept architettonico.
La sua particolare forma ad anfiteatro ha guidato la progettazione dell’auditorium e dell’impianto urbano. La proposta di Settanta7 si è distinta per un approccio fortemente innovativo, in netto contrasto con la maggior parte delle soluzioni concorrenti. La scelta del team è ricaduta su un’articolazione in padiglioni immersi nel verde, privilegiando il dialogo tra gli edifici e lo spazio aperto, in linea con l’identità di un campus contemporaneo.
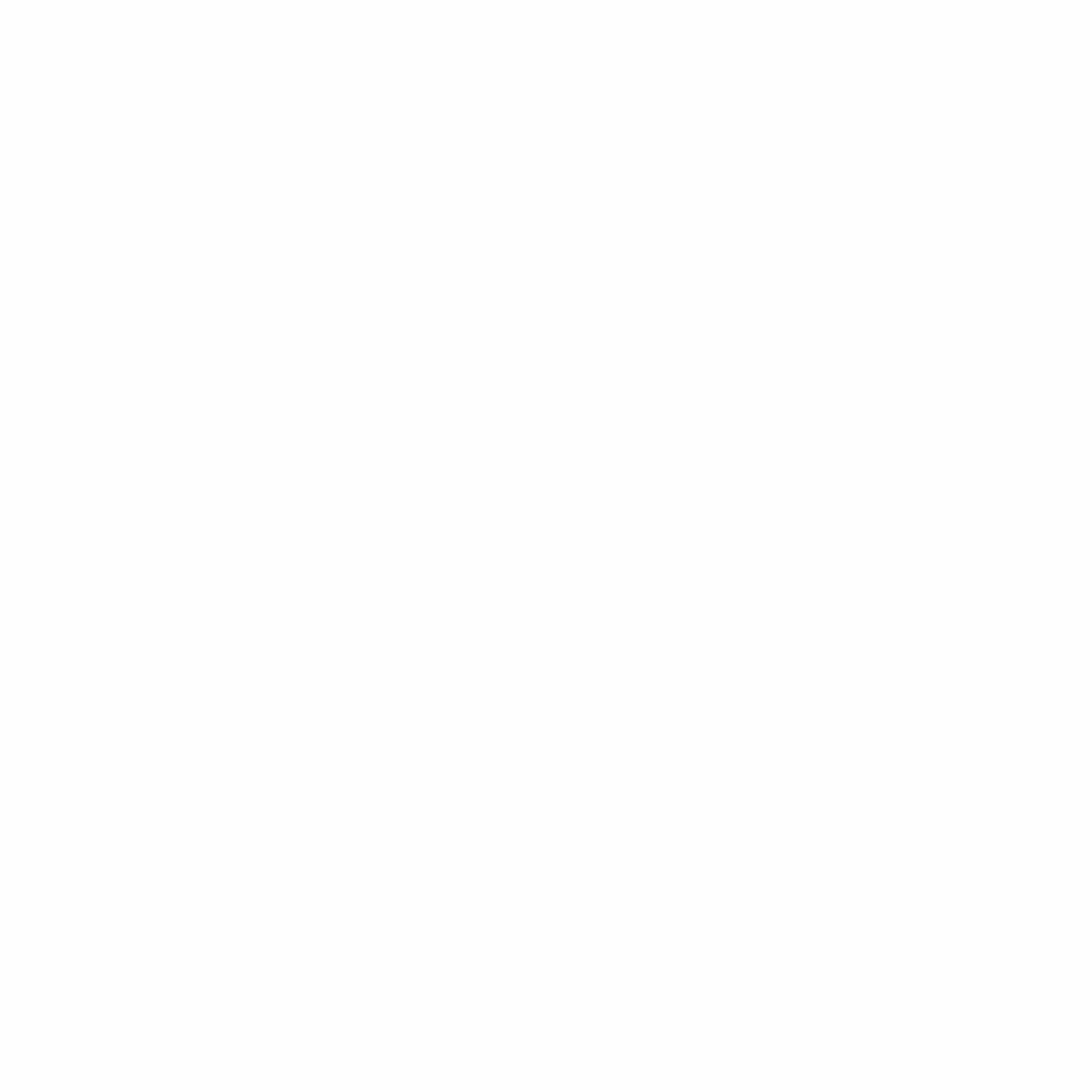
Arch. Carla Rubattu – SETTANTA7
“Dialogo tra edifici”
“La proposta è stata selezionata perchè diversa e in antitesi alla maggior parte delle altre, che presentavano ipotesi con un unico volume che andava a occupare e a saturare la quasi totalità del lotto, rendendo poi la parte risultante una corte interna a servizio del fabbricato del conservatorio.“
Morfologia, funzioni e materiali
Il masterplan prevede edifici distinti per funzioni, ciascuno con una propria identità formale e architettonica:
- Auditorium: cuore simbolico del progetto, rievoca la forma della palazzina ex-Chimici e si affaccia direttamente sull’infrastruttura stradale. Può ospitare circa 400 persone ed è rivestito con un innovativo sistema ceramico customizzato, articolato in sette cromie differenti.
- Scuola di Musica Elettronica: ospita anche la mensa, un bar e spazi comuni. L’edificio integra sale prova e studi di registrazione, progettati con elevati standard di acustica.
- Residenza per Studenti: struttura dedicata all’alloggio degli studenti.
- Palazzina ex-Chimici: oggetto di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione, diventerà la sede della scuola di rock, pop e jazz del Conservatorio.
I volumi sono caratterizzati da forme fluide e dinamiche, ispirate sia alla struttura della foglia che alla propagazione delle onde sonore.
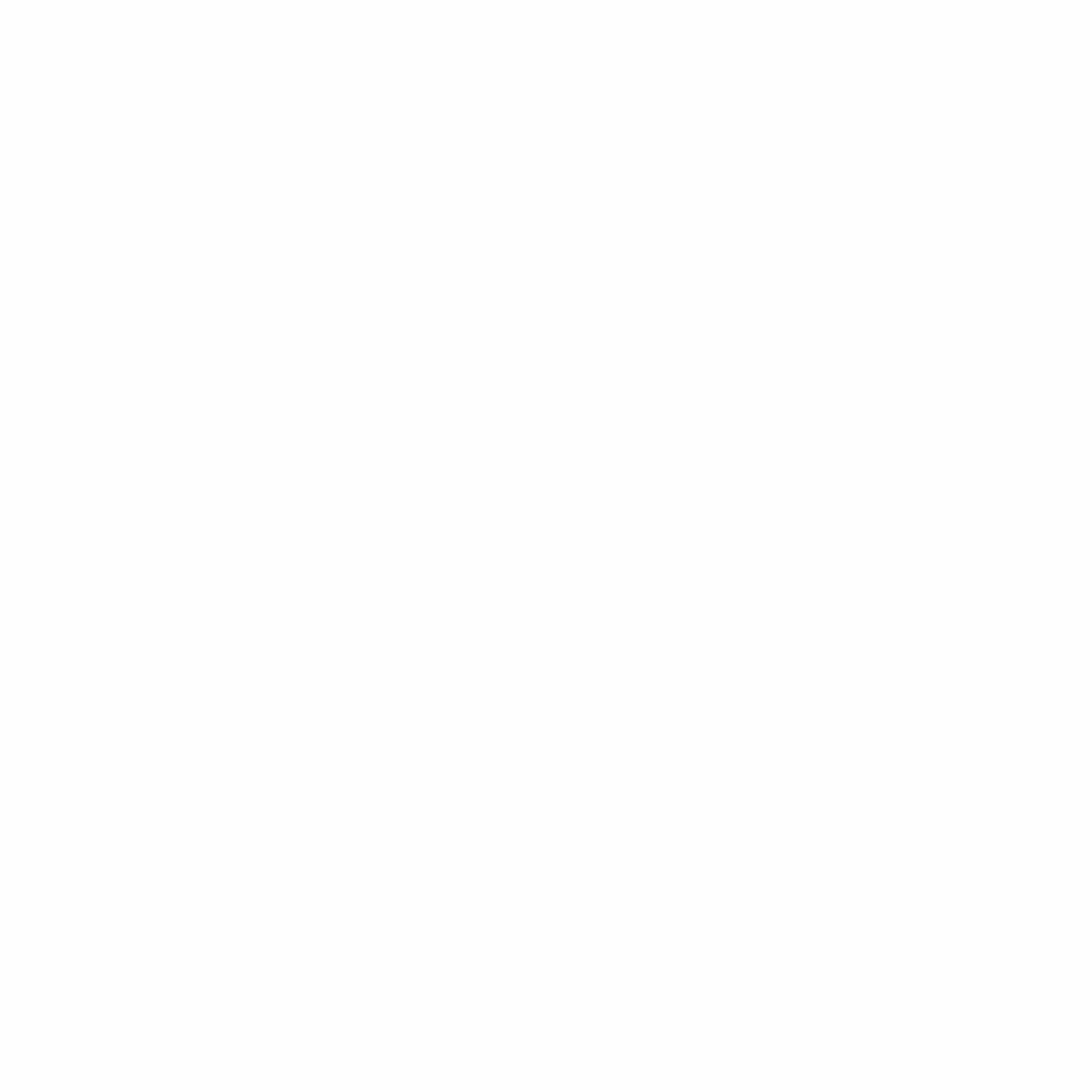
Materiali e rivestimenti: tra estetica e durabilità
I materiali selezionati rispondono a criteri di sostenibilità, durabilità e manutenzione ridotta, condizione importante per garantire agilità e longevità nella gestione delle strutture.
Le facciate continue in vetro si alternano a rivestimenti in lega preossidata di rame e stagno, mentre i basamenti sono definiti da grandi lastre ceramiche.
L’Auditorium, in particolare, è rivestito con elementi romboidali in ceramica realizzati su misura in collaborazione con Gruppo Bardelli – Arch. Rubattu
Il rivestimento è composto da sette tonalità: tre neutre e quattro metallizzate, scelte dopo numerose prove con il team interno dell’azienda.
Questa soluzione – riflettente e a mosaico – è stata pensata per trasformare l’Auditorium in un landmark urbano riconoscibile.
Gli altri edifici, invece, riprendono cromie terrose, in contrappunto con l’edificio iconico. I materiali impiegati sono stati selezionati anche per le loro prestazioni tecniche: il rivestimento in lega preossidata, ad esempio, garantisce una protezione naturale nel tempo – Arch. Valente
La realizzazione delle geometrie curve ha richiesto un sistema strutturale flessibile. Le indagini geologiche hanno evidenziato criticità nel terreno, che hanno imposto adattamenti al progetto esecutivo senza tuttavia snaturarne l’impianto concettuale.
Il processo progettuale ha coinvolto strutturisti e architetti sin dalla fase concorsuale, in un approccio integrato che ha consentito di armonizzare estetica, funzionalità e vincoli tecnici.
Sostenibilità e tecnologie a impatto zero
Il progetto ambisce alla neutralità energetica, puntando su fonti rinnovabili e sistemi impiantistici all’avanguardia.
Tutti gli edifici saranno dotati di coperture fotovoltaiche, mentre il sistema di climatizzazione è affidato a pompe di calore geotermiche.
Il complesso non sarà allacciato alla rete gas e anche le cucine del ristorante saranno completamente elettriche.
Il cuore tecnologico è collocato nel piano interrato, dove si trovano anche le sale prova, per minimizzare l’impatto acustico verso le abitazioni vicine.
Il verde gioca un ruolo fondamentale nella definizione del progetto, sia in chiave estetica che funzionale.
Le coperture verdi, i movimenti di terra e le collinette fungono da barriera acustica e da elemento di mitigazione ambientale.
La scelta di essenze a bassa manutenzione riflette una visione sostenibile e resiliente dell’ecosistema urbano.
Foto ©Paris Render
Spazi aperti e comunità: il campus come bene comune
Il “Bosco della Musica” è pensato come un luogo aperto, capace di dialogare con la comunità. Gli spazi al piano terra – come la mensa – saranno accessibili anche al pubblico in orari extra scolastici.
L’impianto degli spazi è flessibile, modulabile per accogliere eventi, attività culturali e nuove forme di aggregazione – Arch. Rubattu
La fase di progettazione è stata completata a settembre 2024 ed attualmente sono in corso le procedure per la definizione dell’impresa esecutrice dei lavori, con inizio di questi ultimi previsto per l’estate 2025.
In questo intervento lo studio Settanta7 ha dato fondo al suo approccio, attento al contesto e orientato all’inclusione. Un concetto rivolto all'”architettura” pensata per essere vissuta, accessibile, sostenibile, capace di evolvere con il tempo e con la comunità che la abiterà.
“Ciò che ci distingue è il nostro approccio al progetto, fondato sulla ricerca di un dialogo autentico con il contesto progettando con equilibrio e sensibilità per dare forma a un’architettura che ne rifletta l’essenza in modo armonioso e originale.”




