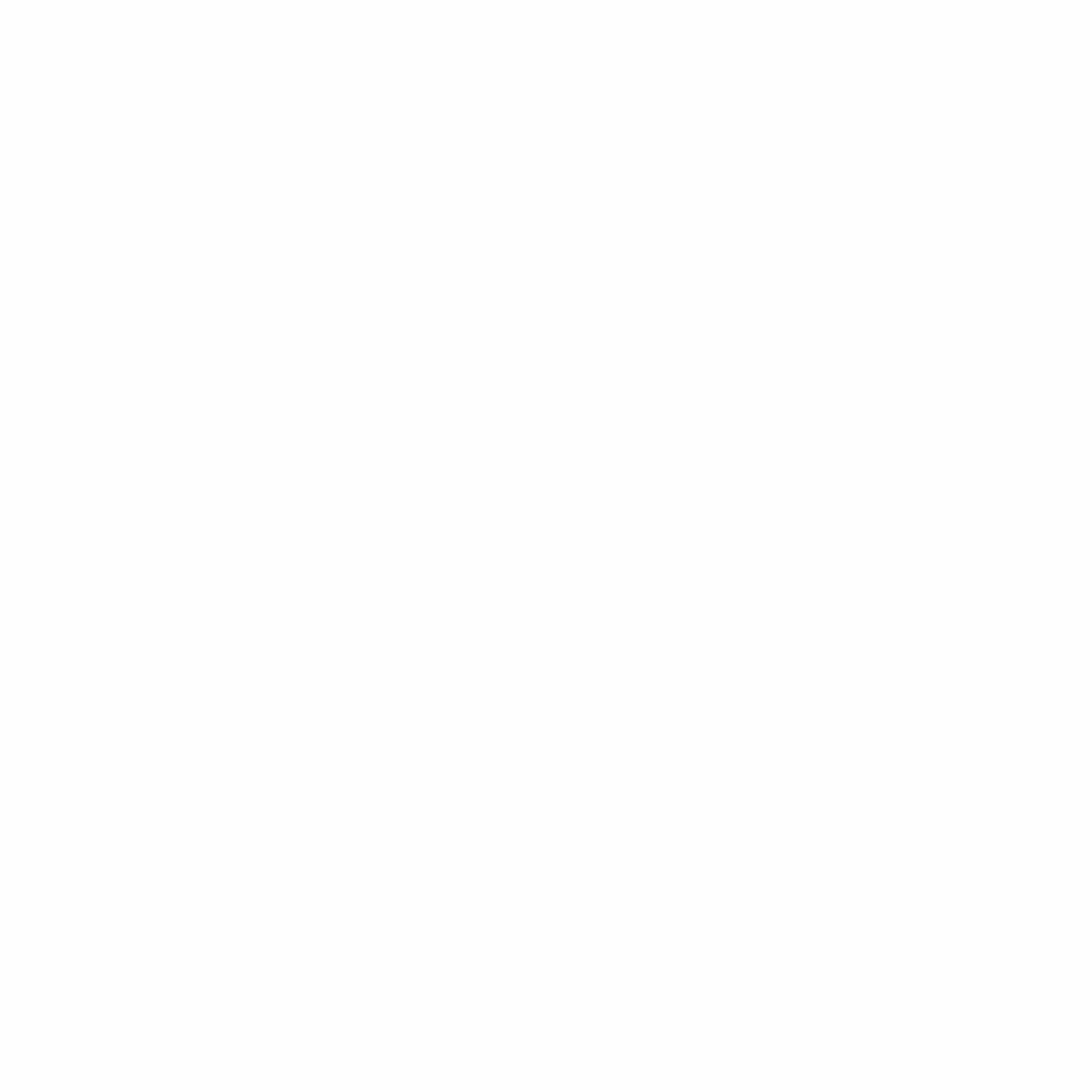
Società di progettazione e direzione lavori
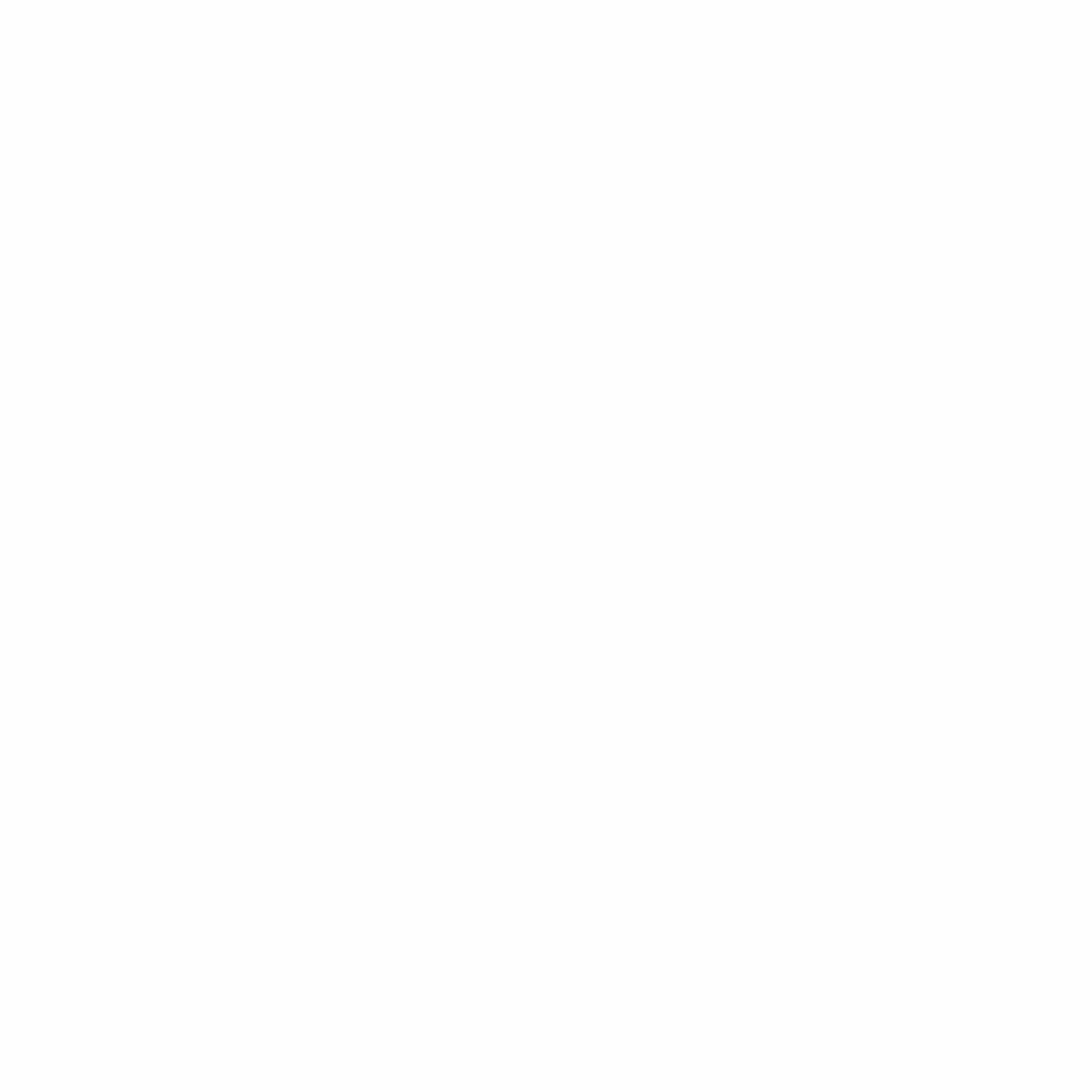
Il panorama della mobilità urbana fiorentina è in continua evoluzione, e uno dei progetti chiave per il futuro della città è la realizzazione della nuova tramvia catenary free 3.2.1, destinata a collegare Piazza della Libertà con Bagno a Ripoli. Questo ambizioso intervento non rappresenta solo un potenziamento del trasporto pubblico, ma anche un’opportunità di riqualificazione urbana e di introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, come la significativa tratta senza alimentazione a catenaria. Architecna Engineering, una società di progettazione con una solida esperienza nel settore, riveste un ruolo cruciale in questo processo, occupandosi non solo della progettazione ma anche della direzione lavori
Per comprendere appieno la portata di questo intervento, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare l’Ing. Pietro Caminiti, Direttore Tecnico, BIM Manager e Direttore Operativo Infrastrutture di Architecna, e l’Arch. Vincenzo Saporito, componente del team di direzione lavori in qualità di CDE Manager e Ispettore di Cantiere.
Negli ultimi anni, sempre più città italiane stanno investendo nel tram come soluzione di mobilità urbana. Rispetto alle metropolitane, il tram rappresenta un’infrastruttura più agile, con costi inferiori e tempi di realizzazione più contenuti.
Ciononostante, la realizzazione di interventi infrastrutturali in contesti urbani genera alti livelli di complessità operativa e richiede capacità di coordinamento continuo e costante tra i vari soggetti coinvolti.

Firenze è un caso particolare rispetto ad altre realtà italiane.
Nel 2005 ha aggiudicato la gara per la concessione del sistema tramviario fiorentino per diverse linee. All’interno del concessionario, Tram di Firenze S.p.a., confluiscono diversi soggetti, tra cui un RTI formato da alcune delle migliori realtà al mondo nella costruzione di tram come Hitachi e Alstom, CMB (Soc. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi), Mermec e Com.Net. Poi c’è il gestore, GEST, una società formalmente al 100% di proprietà della RATP francese, che gestisce il tram di Parigi. Infine, c’è il soggetto per l’ingegneria, Architecna Engineering (Architecna), che si occupa della progettazione definitiva e della Direzione Lavori.
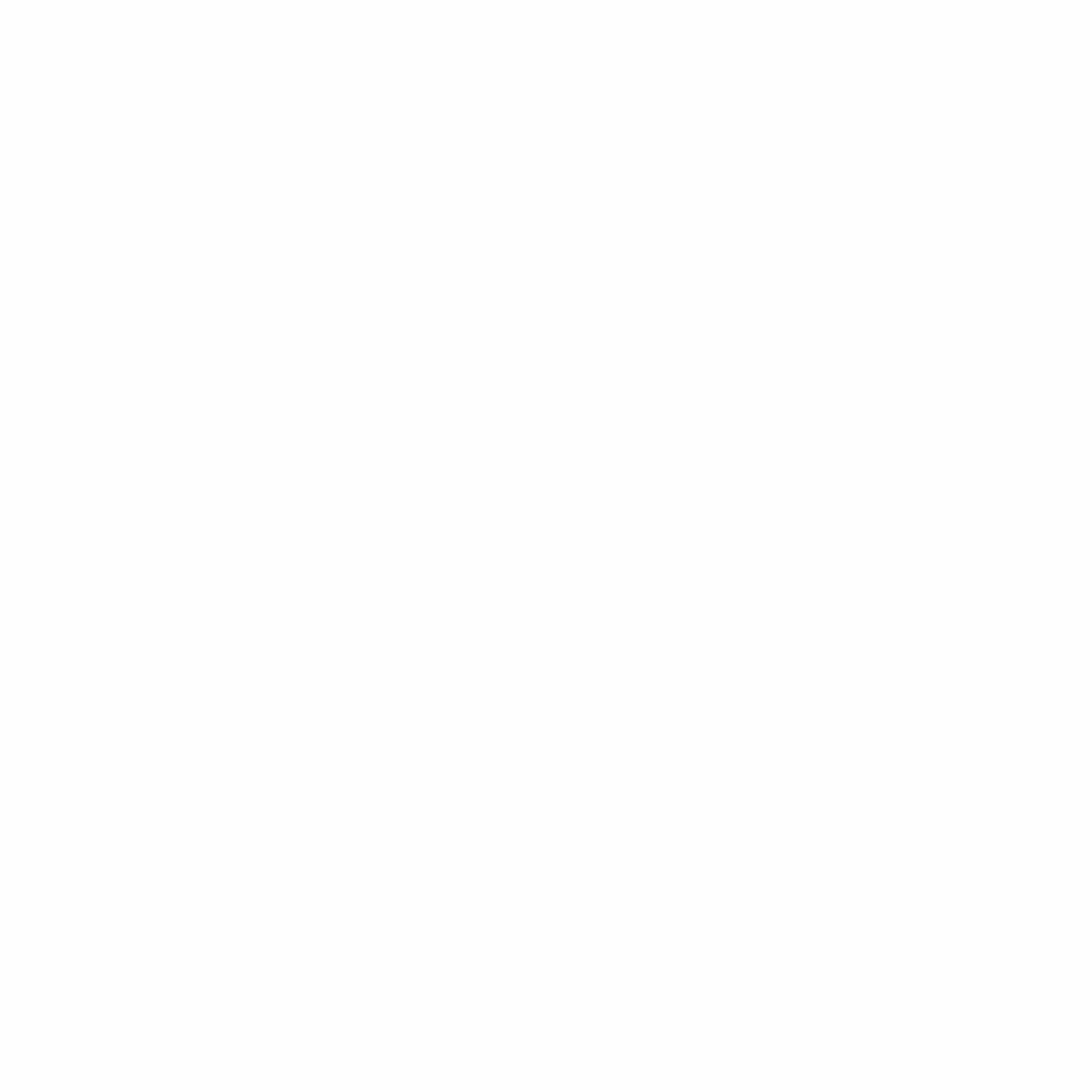
Realizziamo un definitivo come se fosse un appalto integrato, compreso il PSC finale, mentre il progetto esecutivo, trattandosi di un appalto integrato, è stato redatto dal Soggetto Costruttore (RTI) sulla base sia tecnica che economica del progetto definitivo. Architecna si occupa della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
In una città a forte vocazione artistica e monumentale, ogni angolo è una potenziale quinta di bellezza da ammirare e valorizzare. Come coniugare funzionalità e rispetto per il contesto in un sistema tranviario in espansione? Il progetto della linea 3.2.1 introduce un elemento di forte innovazione: una tratta significativa senza alimentazione a catenaria.
“Questa è la prima linea di Firenze che ha una parte di linea col sistema “catenary free”. In particolare, i viali di circonvallazione, il ponte da Verrazzano e viale Giannotti saranno senza catenaria, il che ovviamente è molto importante per Firenze e la sua comunità, soprattutto dopo le grandi critiche che ci sono state all’apertura delle linee 2 e 3 in zona stazione, dove, a causa delle presenza di curvature importanti, è stato necessario installare numerosi pali della trazione elettrica.
Di conseguenza, la cittadinanza ha sollevato la questione in termini di impatto visivo. Sulla scia di quell’esperienza, in questo progetto Firenze esordisce con un primo tratto senza catenaria e sarà probabilmente la prima linea d’Italia con questa caratteristica (anche Bologna è impegnata in tal senso, ndr)”.
“Firenze ha fatto scuola perché, ovviamente, propone la prima tranvia moderna in Italia secondo una visione più innovativa”.
Questa concezione di tranvia ha evidentemente un’implicazione, ovvero un costo chilometrico più elevato rispetto ad altre progettualità. Al contempo, come ci spiegano i nostri interlocutori, costituirà un’occasione di riqualificazione di alcune aree cittadine.
La tranvia di Firenze, già con le linee 2 e 3, aveva previsto l’avvio di un processo di riqualificazione urbana delle aree attraversate, non solo lungo il corridoio tramviario, comprendendo il rifacimento, la ripavimentazione e l’arredo urbano di importanti piazze del centro urbano. Marciapiedi, illuminazione, verde, arredo urbano, sottoservizi. Firenze è stata la città che più ha investito nel rifacimento dei sottoservizi. Questo approccio olistico, che include anche un’attenta gestione dei sottoservizi, è diventato un punto di riferimento per altre città italiane.
Il tracciato della linea 3.2.1,intercetta assi viari cruciali e piazze significative della città.
Rispetto alla Vacs, questa linea interesserà una porzione di viali, lato est del centro storico, molto trafficata, e piazze importanti di Firenze come Piazzale Donatello e Piazza Beccaria. Attraversando contesti densamente abitati come Gavinana, si svilupperà in direzione di Bagno a Ripoli.
La scelta di attraversare queste zone è stata motivata dalla necessità di intercettare i flussi di traffico esistenti.
“L’ipotesi di permeare all’interno di piazze e viali importanti era contenuta già nel PFTE del 2008-2010 su input del Comune di Firenze.
Oggettivamente, per intercettare i flussi di traffico, l’unica alternativa che si poteva concretizzare era passare dalle strade parallele, ma la sede ristretta non avrebbe consentito la convivenza di tram e flussi veicolari”.
– Ing. Pietro Caminiti
La realizzazione di un’opera di tale portata in un contesto storico e paesaggistico come Firenze comporta una stretta collaborazione con la Soprintendenza, per la gestione di sfide continue. Ad esempio le due seguenti:
“Abbiamo dovuto affrontare problemi a livello paesaggistico, soprattutto nelle piazze e per la sistemazione urbana dei viali. A seguito di numerosi incontri con la Soprintendenza, è stato ritenuto opportuno, a meno delle aree interessate dalle fermate tramviarie, evitare di spostare i filari di alberi per fare più spazio alla viabilità, affinché rimanesse inalterato l’impianto storico delle alberature voluto dall’arch.Poggi.
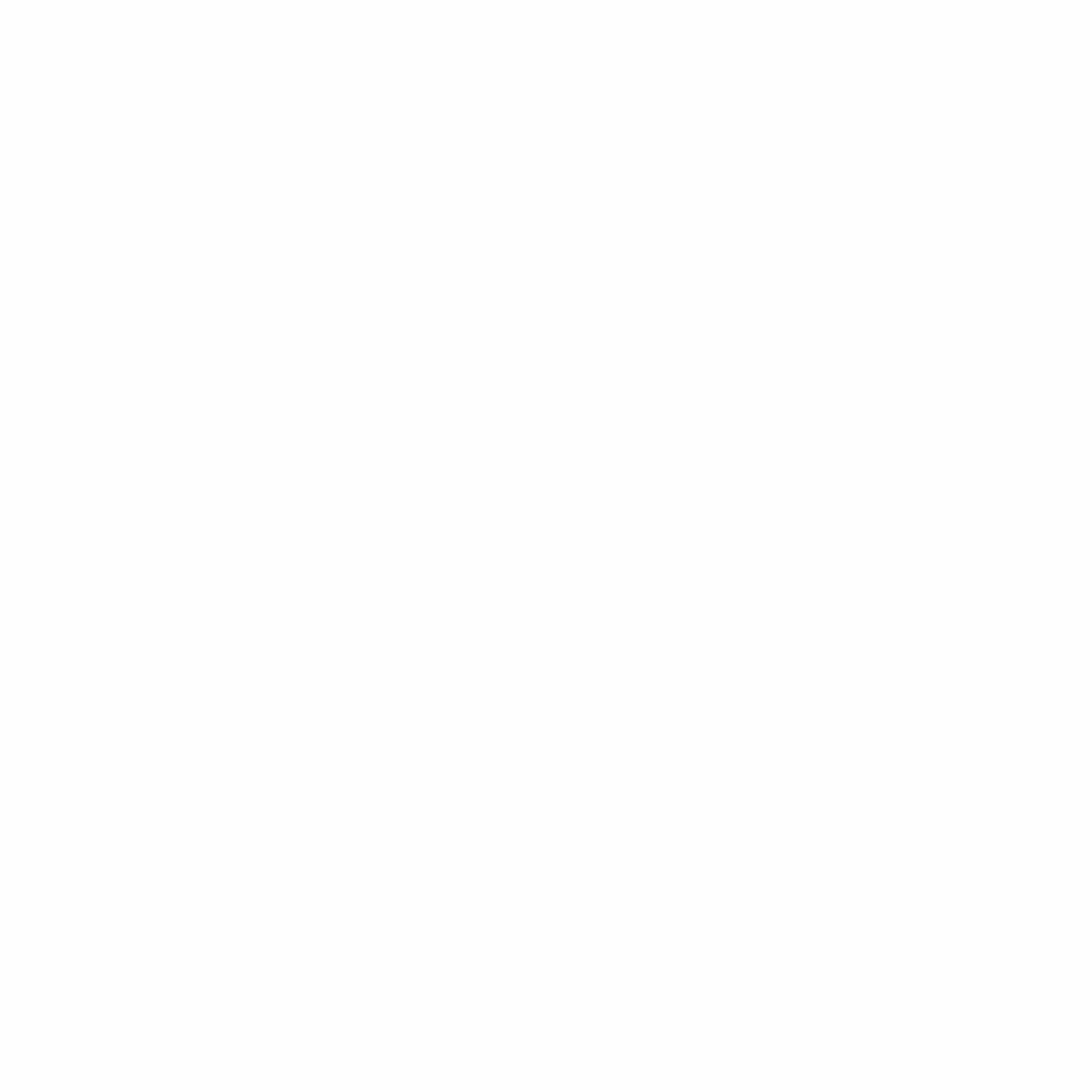
L’altro argomento a lungo dibattuto ha riguardato le fermate sui viali storici fino a piazza Piave, che a differenza della fermata standard con pensilina in vetro opalino chiaro, non avranno la pensilina per non perdere la visione trasversale del viale”.
Non meno importante è stata la gestione delle indagini archeologiche.
“Abbiamo fatto una campagna di indagini e scavi preventivi, lungo tutti i viali di circonvallazione e nella zona di Piazza Beccaria, dove l’archeologia è ‘affiorante’.” In caso di ritrovamenti i lavori si fermano, viene immediatamente informata la Soprintendenza, e si procede alla documentazione e all’eventuale rimozione dei reperti in accordo con le autorità competenti.”
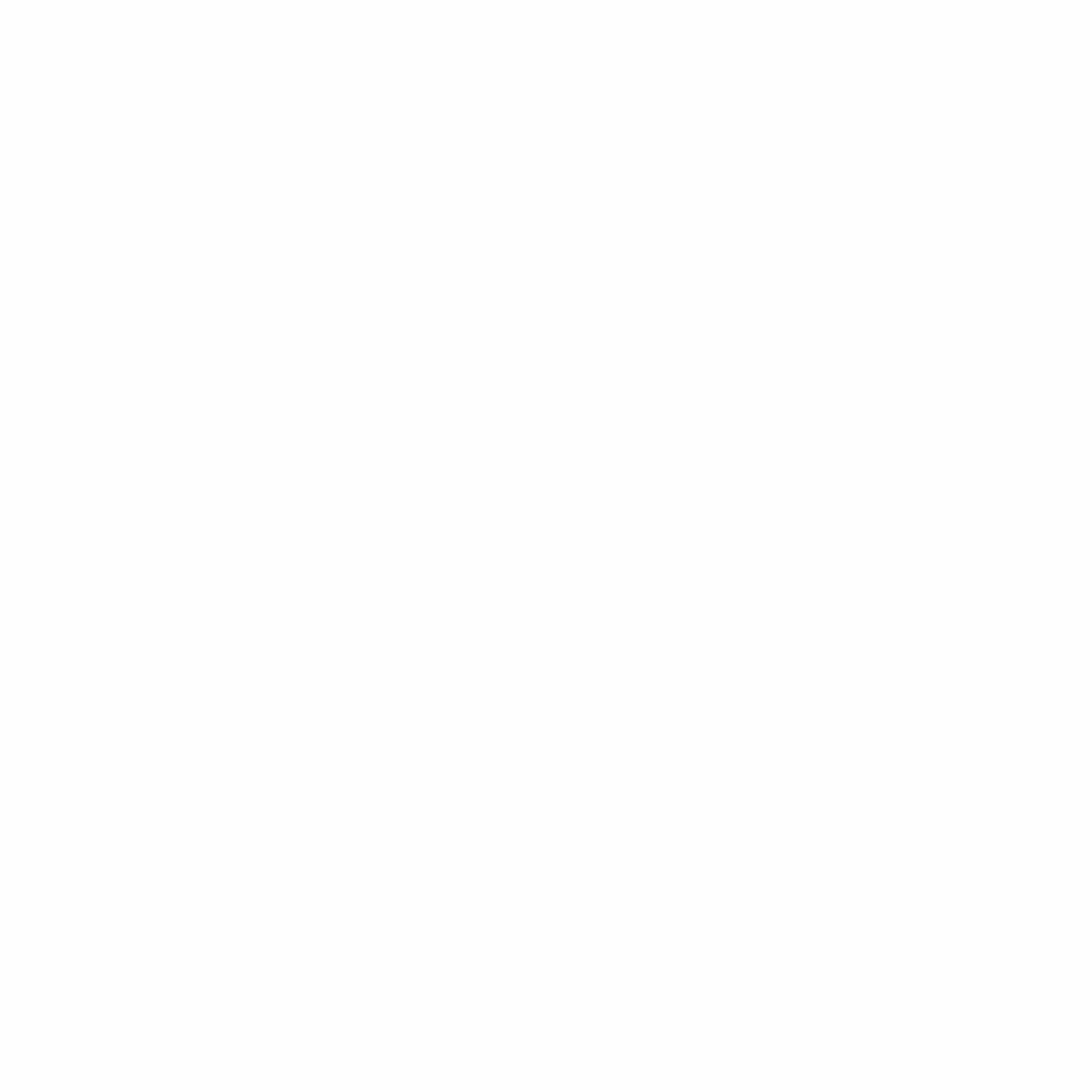
L’avvio dei cantieri è stato graduale, ha precisato l’Ing. Caminiti:
“Abbiamo iniziato con una fase zero, a marzo 2024 circa, che comprende il rifacimento e il potenziamento delle viabilità alternative non interferenti con il tram.
Nel frattempo si è proceduto nella bonifica delle aree dei tre parcheggi scambiatori, del futuro deposito dei tram e del nuovo ponte carrabile sull’Arno. Successivamente è stata approvata la fase uno, che riguarda la realizzazione e il completamento dei parcheggi scambiatori, e poi abbiamo iniziato i cantieri di linea a fine novembre del 2024″.
Dici “tram” e pensi ai binari. Nel concetto di “sistema” di un’infrastruttura metropolitana per la mobilità dolce non sono meno strategiche le opere di servizio e il materiale rotabile.
Un deposito con prato e lucernari sulla copertura disporrà di un grande rimessaggio con annessa stazione e lavaggio dei convogli, officina materiali rotabili, officina impianti fissi e una sottostazione elettrica per tutti i tram della linea 3.2.1 e 3.2.2.“. “Il modello dei convogli è il medesimo delle nuove linee tranviarie di Torino, ovvero il “Sirio” della Hitachi, con la sostanziale innovazione delle batterie in dotazione per transitare nei segmenti privi di catenarie. La ricarica non avverrà lungo le fermate ma lungo tutto il tragitto, tramite il riaggancio alla catenaria nei tratti previsti.
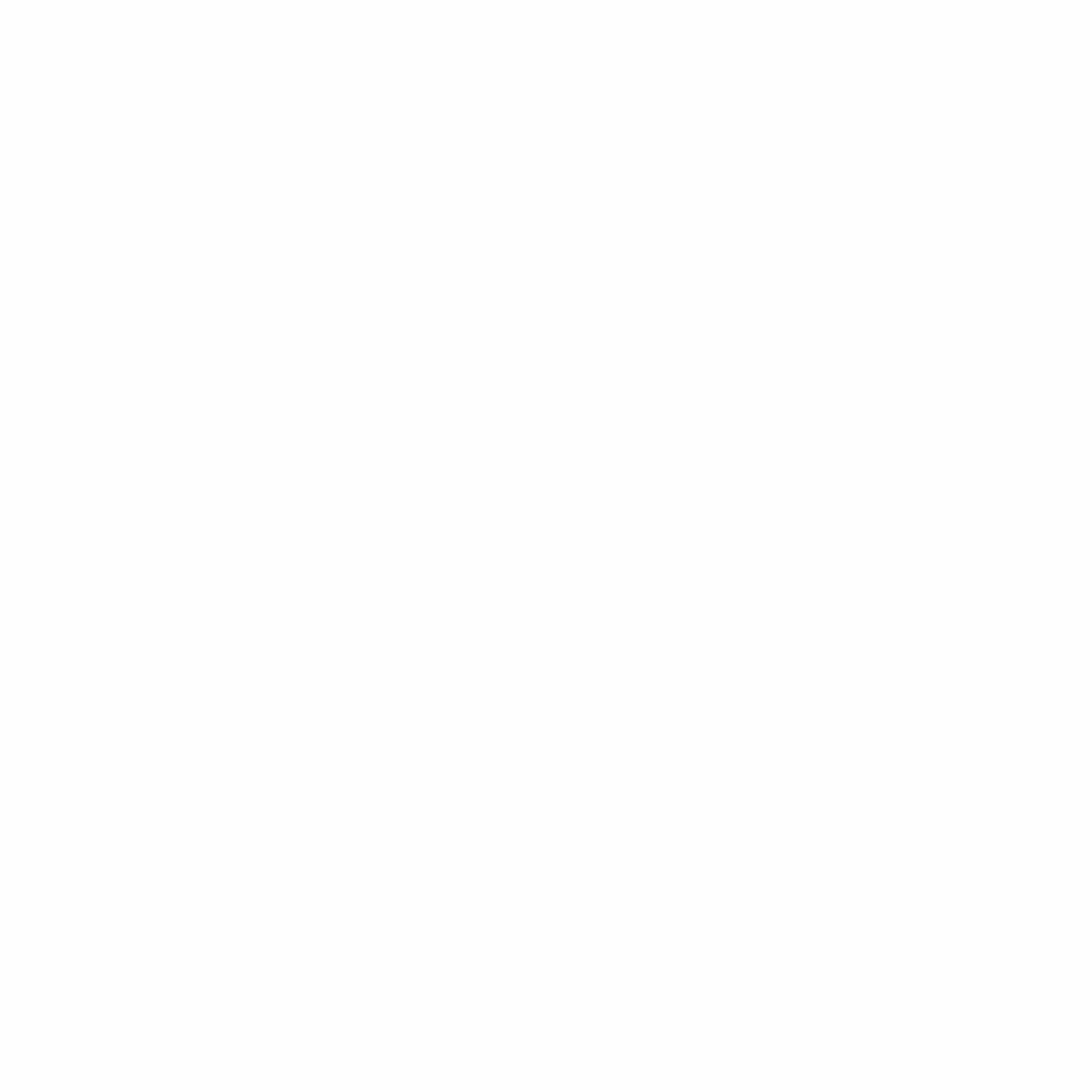
Nonostante le difficoltà legate ai ritardi burocratici e alle condizioni meteo sfavorevoli, il cantiere sta Un aspetto particolarmente complesso nella realizzazione di infrastrutture urbane è la gestione dei sottoservizi, infrastrutture preesistenti alle progettualità, spesso non mappate, che negli anni si ramificano nel sottosuolo delle città senza il necessario ordine e monitoraggio.
Sebbene la realizzazione di una sede tranviaria non preveda scavi particolarmente profondi, tanto basta per intercettare questo dedalo di cavi, e tubazioni di competenza dei rispettivi enti gestori.
Insieme ad Architecna abbiamo voluto quindi comprendere come la direzione lavori approccia questa delicata fase dell’iter cantieristico.
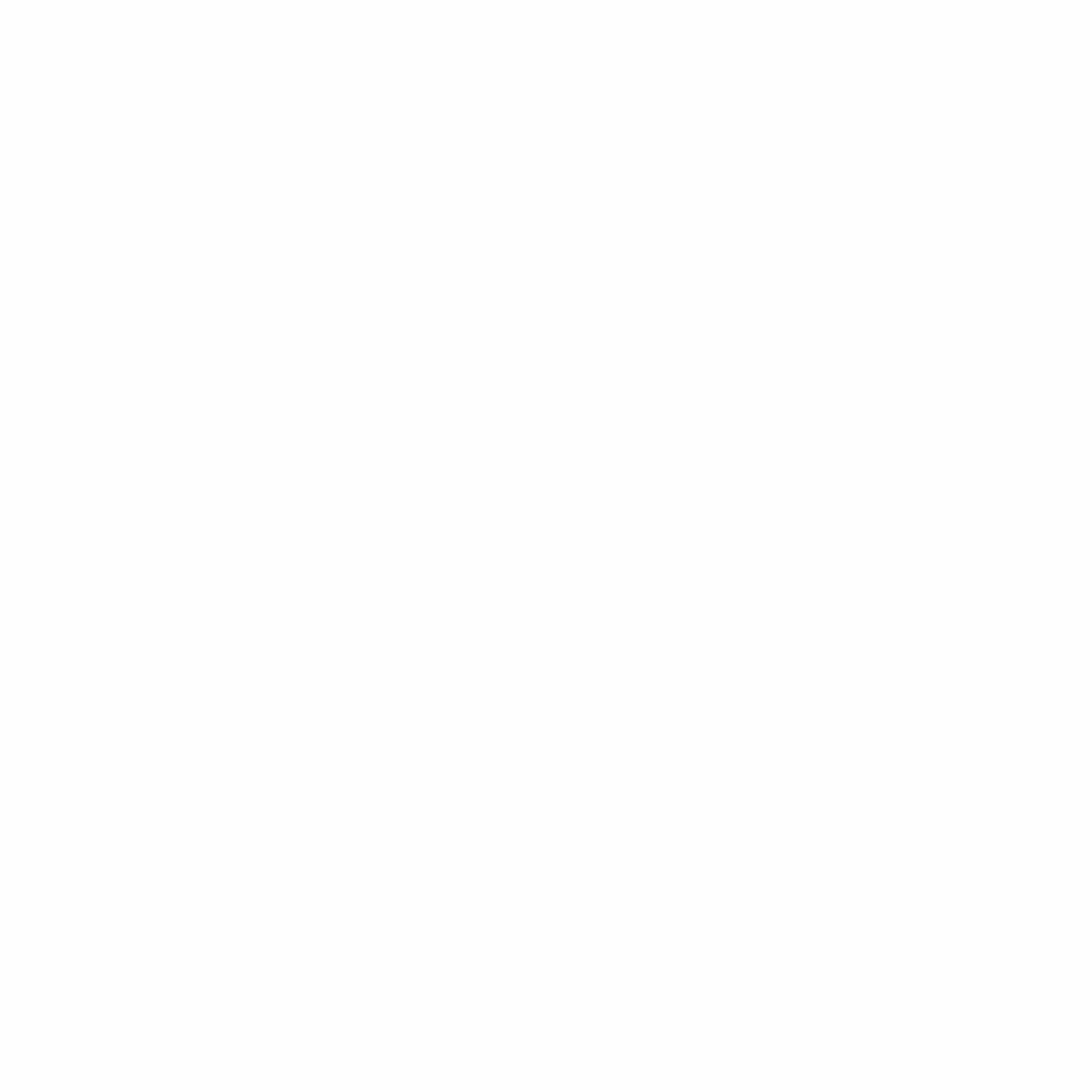
“Negli ultimi anni, ci stiamo orientando a spostare al di fuori della tranvia tutto ciò che è in pressione, come gas e acquedotto, seppur non interferenti fisicamente“
— Ing. Pietro Caminiti
“Come prima cosa, contattiamo gli enti gestori, forniamo il tracciato previsto della linea e chiediamo loro cartografie in un’ampia fascia intorno al tracciato stesso. Spesso i dati che riceviamo non sono molto precisi. Quindi, integriamo con rilievi topografici dettagliati, sopralluoghi in campo, per verificare la corretta segnalazione dei tombini, e, grazie alla nostra esperienza, riusciamo a ricostruire una prima cartografia dello stato di fatto. Fatto ciò, eseguiamo indagini integrative come videoispezioni delle fognature, georadar e, soprattutto, l’apertura dei pozzetti esistenti con rilievo laser scanner interno per ottenere una scansione 3D dettagliata”.
L’obiettivo è minimizzare le interferenze e garantire la continuità dei servizi.
“Negli ultimi anni, ci stiamo orientando a spostare al di fuori della tranvia tutto ciò che è in pressione, come gas e acquedotto, seppur non interferenti fisicamente. Se sono strutture trasversali, li rifacciamo e li incamiciamo per prevenire problemi futuri.
Per le fognature, se non in cattive condizioni, vengono mantenute al di sotto con accessi laterali per la manutenzione.”
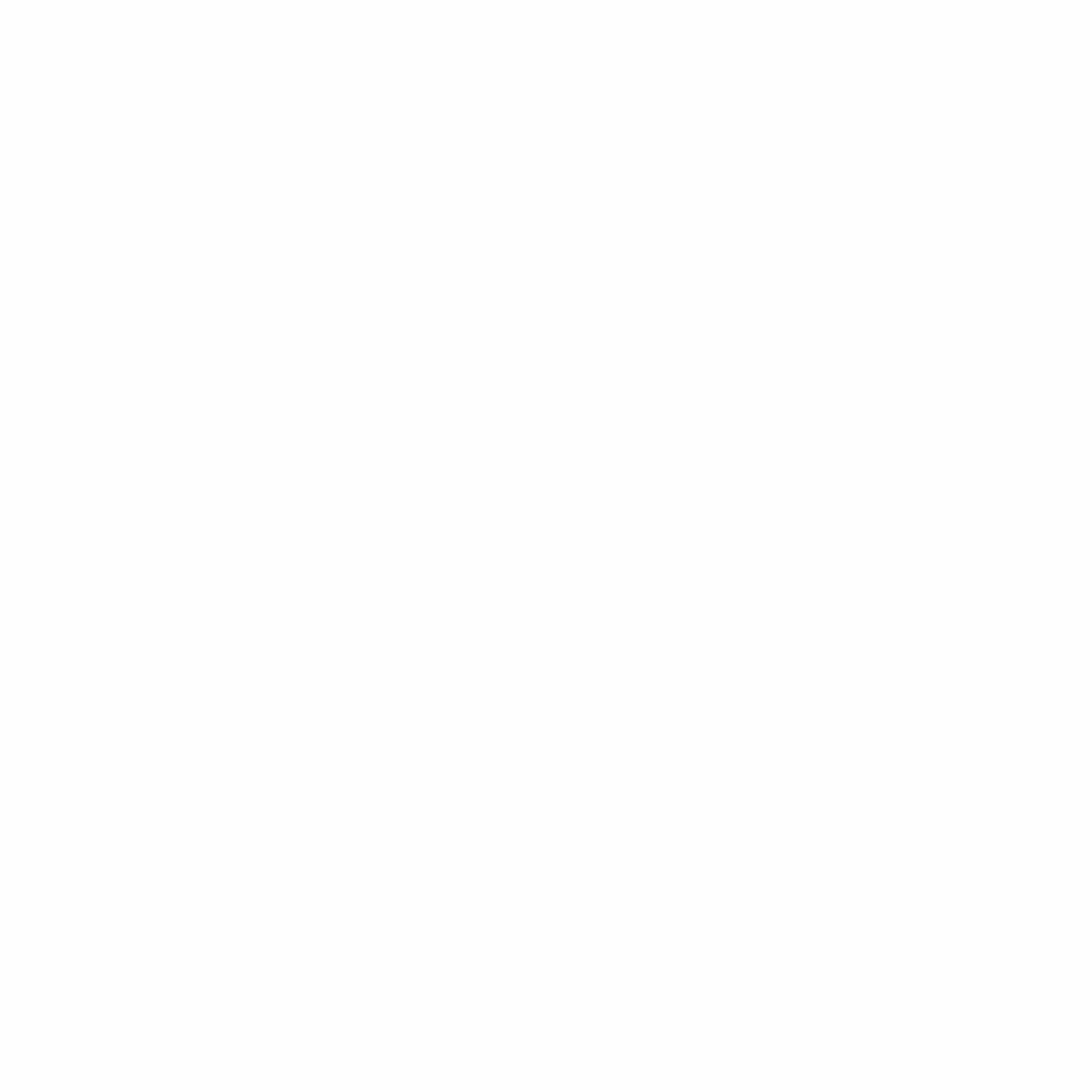
La realizzazione della nuova tramvia catenary free di Firenze rappresenta un intervento complesso e articolato, che integra sfide ingegneristiche, architettoniche, paesaggistiche e sociali. Costituisce anche l’opportunità di sperimentare alcune innovazioni tecnologiche. Parliamo di un ballastless track systems, ovvero di un sistema di armamento innovativo, Embedded Rail System (ERS) già adottato sulle linee 2 e 3, progettato per ridurre le vibrazioni in prossimità di edifici sensibili. Questo sistema prevede due spesse solette in c.a. (di prima e seconda fase) in cui si interpongono dei materassini antivibranti che abbattono le vibrazioni provenienti dalla sede tranviaria.
Ricerca tecnologica che, unitamente a competenza e dedizione, sono i pilastri su cui si fonda il lavoro di un team allargato. Al termine di questo excursus sul progetto tram di Firenze ci siamo chiesti se in mezzo a tanti tecnicismi ci sia spazio per indagare un pò l’ispirazione a cui anche gli ingegneri si appellano. L’Ing. Caminiti conclude così la nostra chiacchierata:
“
Abbiamo studiato i tram di Tolosa, Nizza, Parigi, Siviglia. Diciamo che il modello francese è quello che riteniamo all’avanguardia sia per la gestione che per l’esecuzione di questo genere di opere.”
Noi ci ispiriamo ai progetti francesi e in parte anche alla Spagna e al Portogallo.
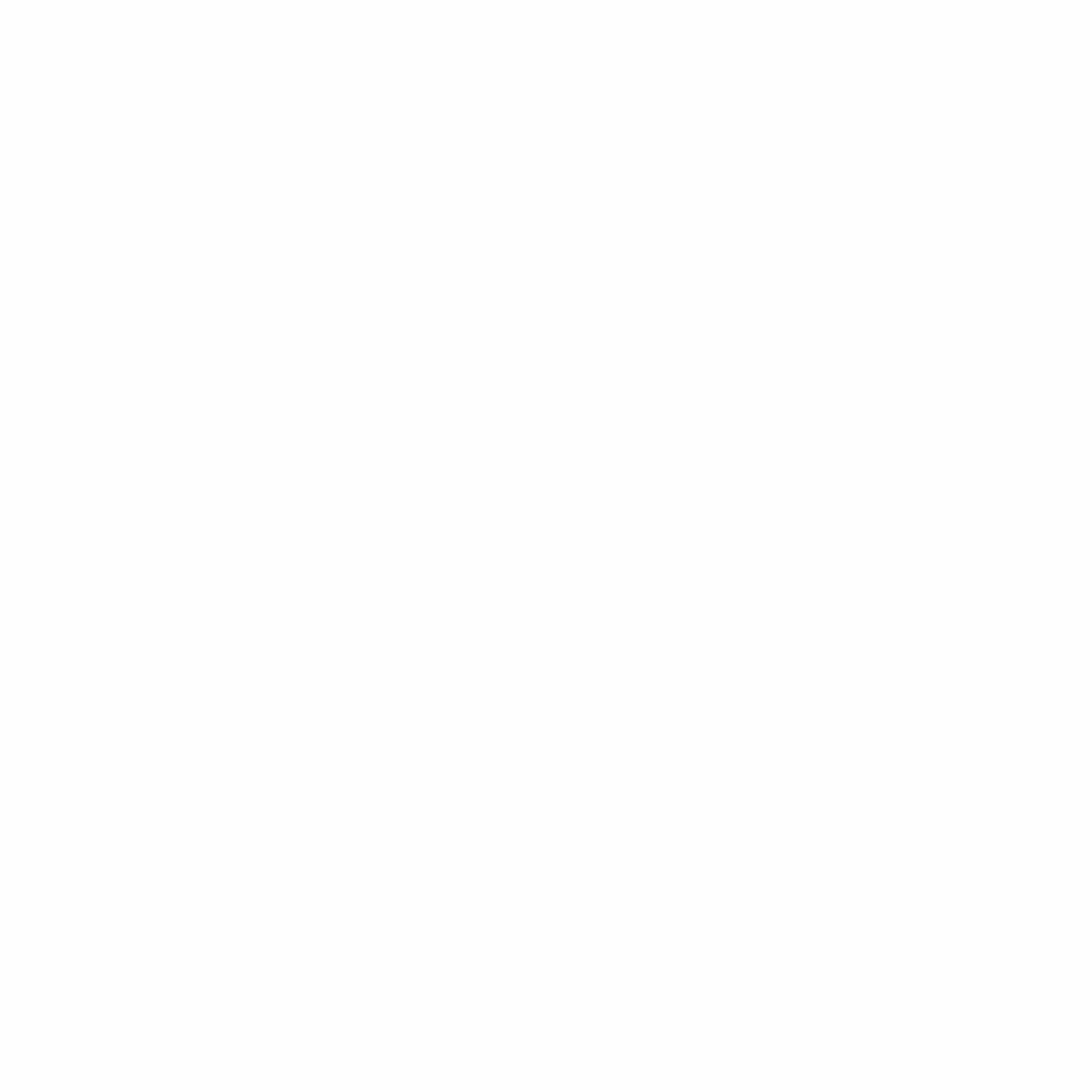
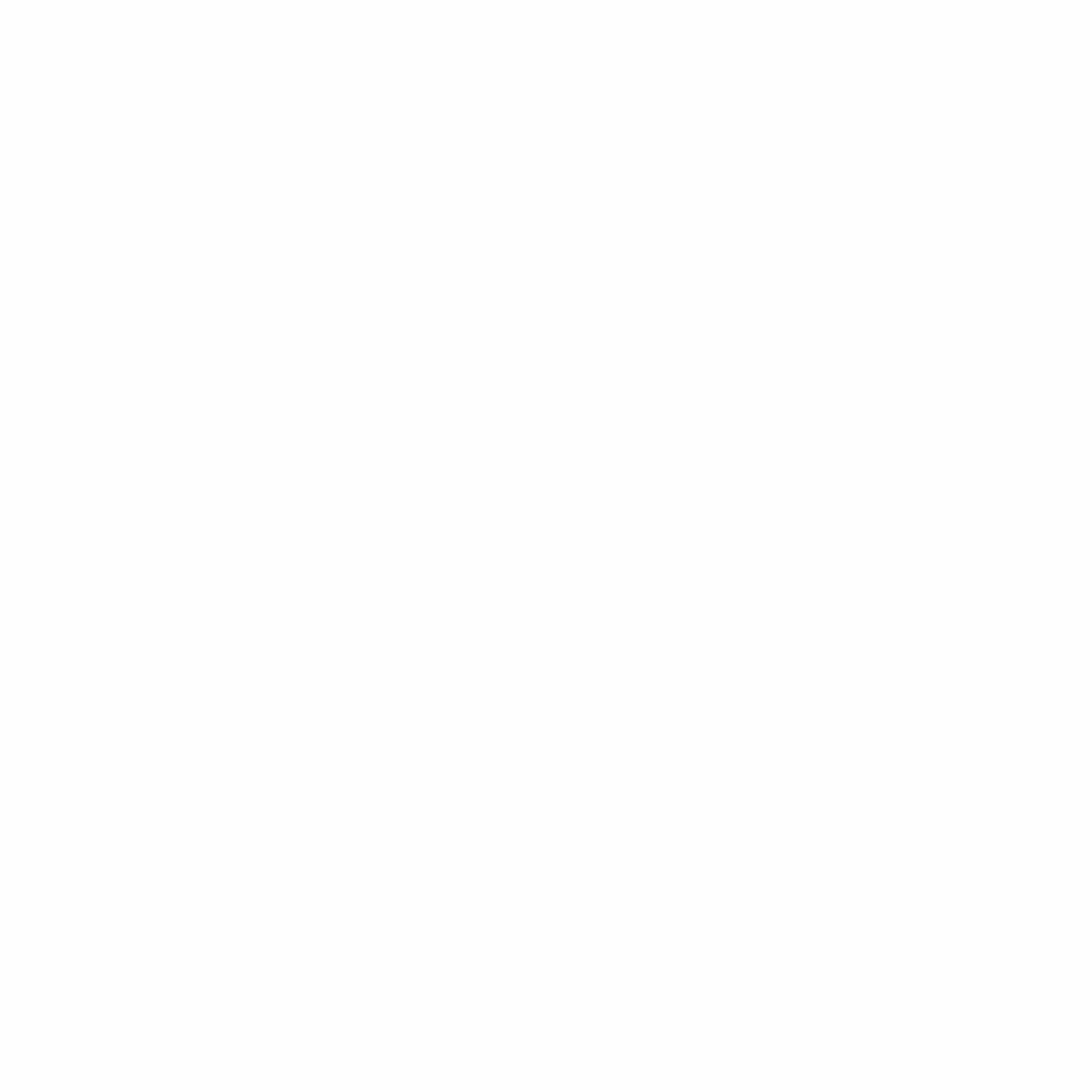
Non saremo invasivi, ti proporremo solo il meglio.